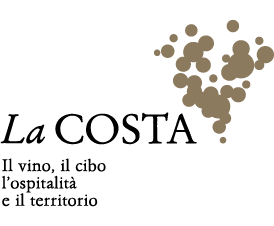Igt Terre Lariane, un vino che vuole essere protagonista
Incontro con Claudia Crippa, presidente di Igt Terre Lariane, che ha spiegato come piccole realtà vogliono tornare protagoniste della viticoltura italiana
«Siamo piccoli, ma cresceremo. E sogniamo in futuro in grande». Igt Terre Lariane è un consorzio giovane, molto giovane: anzi, con i suoi soli sette anni di vita (si è costituito ufficialmente nel 2009, anno del riconoscimento, e la fondazione risale al 2008) ha da poco iniziato le scuole primarie. Eppure, di strada ne ha fatta in questi pochi anni, si è sviluppato come numero di soci. «Siamo partiti in sette – ha spiegato Claudia Crippa, presidente del consorzio – ora siamo sedici e altri due coltivatori sono in ingresso». Una realtà che ha saputo imporsi come rappresentante credibile del mondo della viticoltura in Brianza e sul lago di Como, le sue due principali zone di riferimento. E sempre con un occhio all’innovazione e al futuro. Con lei, abbiamo ripercorso un po’ la storia di questa piccola realtà di ancor più piccoli viticoltori – c’è chi non arriva nemmeno all’ettaro di vitato – che in pochissimi anni ha saputo cancellare decenni di cattiva fama. E gli occhi sono sempre più puntati verso il futuro, verso nuovi sviluppi, verso un’innovazione che ha radici profonde nella tradizione.
Questo territorio non è famoso per il vino, anzi?
«Como e Lecco hanno sempre avuto la nomea di zone dove non si produce vino buono: una cattiva fama che derivava più da questa incapacità di lavorare insieme, e dalle poche risorse che ogni viticoltore poteva mettere in gioco, per cui la spremitura era fatta a mano, o meglio con i piedi come si diceva una volta, il trasferimento del vino avveniva con i secchi, con i problemi di ossidazione e di contaminazione che possiamo aspettarci, che dà una effettiva verità».
Ma non è sempre stato cosi?
«Storicamente se andiamo indietro nei secoli, vediamo che tra le colline brianzole e il lago di vino se ne produceva e anche di buona qualità. Basta leggere quanto ci hanno lasciato storici e scrittori del passato: Stendhal, Cesare Cantù, Carlo Porta, Alessandro Manzoni. Decine di anni di abbandono e di poca cura hanno fatto sì che si parlasse di nostranel, di pincianel, per indicare i vini brianzoli e del lago erano roba di poco conto. Il consorzio ha lavorato per dimostrare che questo non era vero. A distanza di così pochi anni, nemmeno una decina, dalla costituzione del consorzio, possiamo dire di essere riusciti a cambiare le cose: oggi il nostro vino non sfigura anche sulle migliori tavole».
Come consorzio cosa avete fatto per cambiare questa situazione?
«Uno dei primi lavori che abbiamo fatto come consorzio è stato di prendere la cooperativa Ager, che collabora con l’Università di Milano, per fare una mappatura. Non una zonazione vera e propria, perché all’epoca le aziende del consorzio e i vigneti erano ancora pochi. Era il 2008, Igt Terre Lariane si è costituito ufficialmente nel 2009. Il lavoro realizzato con Ager e l’Università di Milano è un monitoraggio e una fotografia dei diversi tipi di clima e terreno nell’area. Siamo partiti in sette, adesso siamo in sedici, qualcuno è entrato, qualcuno è uscito, ne sta entrando uno della zona est della Provincia di Como, ne entrerà un altro di Perledo, sulla sponda lecchese del lago. Tutte aziende, qualcuna anche micro, addirittura sotto l’ettaro. Però in sviluppo. C’è chi ha piantato il primo mezzo ettaro, e adesso sta lavorando per allargarsi. Vedono il futuro, insomma. Perché chi pianta la vite ragiona in termini di una decina di anni almeno: la vigna non è un bot, non dà risultati economici in brevissimo tempo, si parla di anni e anni».
Questi ultimi anni hanno messo a dura prova la capacità del consorzio di fare gruppo?
«Il 2014, un disastro, il 2015, annata super ma quantitativamente poca uva, il 2016, non di facile gestione, soprattutto per chi si è affacciato da poco alla viticoltura. Devo dire che sono stati messi duramente alla prova: a luglio l’umore non era dei migliori, glielo assicuro, però alla fine ce l’abbiamo fatta tutti».
La storia dell’Igt Terre Lariane è ricca di scogli: tutti brillantemente superati.
«Dobbiamo ringraziare soprattutto la Provincia di Lecco, che ha voluto fortemente portare a termine questo progetto dell’Igt. E poi il professor Miglio, da cui è partito tutto».
Qual è stato quello principale che avete dovuto affrontare?
«In Brianza e sul lago la gente è abituata a lavorare da sola, a poco a poco siamo riusciti a far comprendere che lavorare in team è meglio. Di questo dobbiamo ringraziare personaggi come Giacomo Mojoli, che ci ha praticamente costretto un po’ tutti a sederci insieme intorno ad un tavolo e parlare, discutere, fare progetti insieme. Ci ha costretti a ragionare su cosa poteva essere il futuro.
Fino a quel momento, ciascuno di noi aveva piantato vigneti diversi: io avevo Pinot nero, Riesling, altri il Syrah, chi il Merlot e via dicendo. Un vestito di Arlecchino. Certo, l’omogeneità di vigneto non è importante per un Igt, quello che conta è il territorio e il nostro è marcato da un Merlot dalle caratteristiche organolettiche e di sapore comuni e diverse da quelle di ogni altra area».
Questi vini possono avere nella sapidità un elemento comune?
«Si trova soprattutto nei bianchi ma anche nei rossi, quando vengono prodotti bene, salta fuori evidente. È un inizio della tanto famosa mineralità, è proprio la nota salata della marna calcarea che abbiamo noi, poverissima ma ricca di sali minerali. È un fattore che accomuna un po’ tutti i vini dell’Igt Terre Lariane: anche se distribuiti su suoli lontani per geografia, clima e caratteristiche».
Il territorio coperto dal disciplinare del consorzio va dalle colline brianzole sino alle porte di Lecco, sfiorando la Valtellina con l’Alto Lago, e tutti i vini dunque possono ugualmente tutti contare su questa nota sapida?
«Qua a Montevecchia, la sapidità deriva dalla marna calcarea; a Domaso e in Alto Lago in genere, invece, dalla presenza di suoli di origine vulcanica, anche essi caratterizzati da una nota minerale. Poi, certo, sarebbe bello trovare una declinazione comune e proseguire su quella strada. Abbiamo in corso progetti di ricerca e di dottorato, con l’Università di Milano, sul Merlot alla ricerca di quelle caratteristiche aromatiche, tanniche, polifenoliche per trovare quale potrebbe essere la migliore interpretazione comune».
Spazio per sviluppi futuri ce n’è in abbondanza.
«Al catasto vitivinicolo Como e Lecco le iscrizioni sono oltre cento, c’è quindi spazio per aumentare le dimensioni del consorzio. Per questo facciamo corsi di aggiornamento e formazione gratuiti per i piccoli, in parte finanziati dal Pubblico, in parte pagato da noi aziende, per innalzare il livello di formazione e qualitativo di tutti i viticoltori della zona. Certo ultimamente non abbiamo potuto contare sull’aiuto della Pubblica Amministrazione, sono state annate difficili in questo senso. Stiamo portando avanti un progetto che secondo noi darà futuro alla zona, per una cantina comune. Già oggi ritiriamo le uve anche di chi è fuori dal consorzio. Per gli associati, diamo a possibilità di fare vinificazioni in conto lavorazione, come consorzio, sul modello dell’olio: non facciamo una cantina sociale, dove si mette tutto insieme, ma si ritornano a ogni coltivatore le bottiglie prodotte con le sue uve. Questo ha permesso di avere una cantina sola, una pressa sola, una pompa che serve per tutti, serbatoi che servono a tutti. Ognuno esce con la propria etichetta, per il suo orgoglio personale, ma le risorse sono comuni e le spese ottimizzate. E la qualità decisamente migliore».
Un punto debole è l’accesso ai ristoratori?
«Purtroppo qui entrano in gioco anche altri aspetti, di marketing, di distribuzione, di costo. Il nostro vino costa. Siamo piccoli, non abbiamo forza contrattuale, non possiamo paragonarci a certe forze del mondo della produzione vinicola italiana. Poi ci sono molte associazioni che ci chiedono il vino gratis per i loro eventi: “Ma voi dovete farvi conoscere”, ci dicono. Sì, ma le bottiglie che abbiamo sono poche, se le diamo tutte per promozione, le esauriamo subito e poi? Noi di quel vino dobbiamo anche viverci!».
L’innovazione è un altro aspetto importante?
«Voglio ricordare soprattutto il progetto di un vino comune, una cuvée molto particolare, con gli amici di Fellbach, in Germania, i “gemelli” di Erba. Grazie alla spinta della cittadina brianzola, di Lariofiere, di Silvio Oldani, abbiamo fatto questo progetto comune con la Cantina sociale di Fellbach, un territorio storicamente molto importante per il vino. Sono veramente all’avanguardia da questo punto di vista, quasi maniacale la loro cura di ogni singolo aspetto del vigneto, pali sempre nuovi, erbe sempre sfalciate e pulite, una cantina assolutamente funzionale, e poi la parte commerciale, un’enoteca sempre piena di gente che compera e beve. E noi abbiamo sognato: loro hanno Stoccarda, città grande e ricca, proprio sotto la collina delle vigne, noi abbiamo Milano, Como, Lecco…chissà, magari un giorno».